
A cura di Francesco Scifo
The Brutalist, come il titolo che richiama una corrente architettonica che ama esporre il cemento armato in facciate esposte direttamente e senza fronzoli, è un film diretto che colpisce lo spettatore come un pugno nello stomaco per tutte le oltre due ore di durata.
E’ una storia yiddish, molto verista si potrebbe dire, rifacendosi ad un movimento letterario ottocentesco che del realismo estremo faceva la sua bandiera: una vera storia ebraica, dove la terribile realtà della guerra, dell’Olocausto, della creazione dello stato ebraico, restano sullo sfondo ma sono sempre presenti nel dipanarsi della storia; un lungo e tormentato percorso attraverso il racconto della vita dell’architetto famoso László Tóth, ungherese ebreo, reduce dal tentativo di annientamento subito nel campo di concentramento nazionalsocialista e protagonista di una fuga precipitosa negli Stati Uniti d’America.
Il film racconta il vuoto interiore e lo spaesamento di chi era costretto a fuggire da un’Europa contagiata da guerre e persecuzioni per accedere ad una società libera ma corrotta che faceva sì entrare i profughi ma a condizione che rinunciassero totalmente alla loro identità e storia personale: ciò a pena di renderli reietti o di non accoglierli in caso contrario; una società che rifiuta totalmente di comprendere la sofferenza passata dagli ebrei o di alleviare le loro difficoltà d’inserimento, di fatto causate da una vera sindrome da stress postraumatico, come si direbbe se fossero veterani di guerra.
Una società quindi che vuole cancellare, in modo altrettanto brutale delle realtà totalitarie e concentrazionarie di provenienza dei profughi, il passato di chi arriva e senza troppi complimenti. Il motto del film dovrebbe essere “Nessuno può comprendere il tuo dolore se non lo ha vissuto” e László Tóth cerca, infatti, nella droga e nella sua ossessione di realizzare un’opera che realizzi il suo talento tecnico e ideativo, la forza per resistere a questa cancellazione sociale della coscienza del dolore subito; chi arriva nel nuovo mondo è condannato ad essere reietto, se tenta di fare valere il suo passato e la sua vecchia identità. Tuttavia, il protagonista ha un talento come architetto e, pur nella incapacità di sopportare questa cancellazione della sua anima, viene scoperto per caso da un mecenate americano.
Si instaura così un rapporto morboso tra i due nel quale il ricco miliardario vuole usare e dominare il talento dell’architetto per creare un mausoleo della madre morta e lasciare alla sua comunità un’opera architettonica fastosa da ricordare; il tutto in un contesto, a dir poco, tragico ed edipico. Alla volontà di dominio dell’americano fa da contraltare la situazione di totale dipendenza e sudditanza dell’architetto che subisce ogni vessazione dal suo mentore pur di poter realizzare il suo talento, in un crescendo implacabile, ed a volte ossessionante, da tragedia greca e che arriva fino alla violenza sessuale, subita da László Tóth ad opera del mecenate, in un momento in cui l’architetto è preda dell’eroina.
Sullo sfondo dell’intreccio principale tra queste due figure, si dipanano le vicende degli altri protagonisti, i gemelli figli del miliardario eccentrico, la moglie ebrea dell’architetto, anch’essa già giornalista di talento, fortunosamente sfuggita, denutrita e resa paralitica dall’orrore di Buchenwald, la nipote ebrea che la accudisce, anch’essi incapaci di dimenticare gli orrori subiti dai nazisti.
In questo contesto, la società americana appare nella sua totale brutalità affaristica che nulla può comprendere della guerra e della sofferenza subita dai profughi che arrivano, non avendole mai vissute in prima persona. Lo scenario della creazione dello Stato d’Israele, come detto, aleggia nella volontà manifestata dagli esuli ebrei di andare in Palestina per poter vivere, finalmente, in un’altra società formata da chi invece ha subito la realtà terribile concentrazionaria come gli esuli e che solo può così comprendere le anime di chi è stato torturato e violentato dalla persecuzione razziale e poi ora, di nuovo, anche se in modo diverso, dal tentativo annichilente di assimilazione forzata americana.
Lo stile architettonico brutalista dà il titolo al film, in un’assonanza che appare davvero non casuale con le vicende dirompenti e tragiche dei protagonisti, mostrate sempre davvero brutalmente, con gli stessi toni grigi e impattanti delle facciate spoglie dei palazzi in cemento armato delle architetture brutaliste. La vita di László Tóth è quindi la metafora di chi ha sofferto ma non viene compreso ed è costretto a convivere da solo con la sua terribile sorte passata e con un futuro che ne cancella l’anima come prezzo per l’assimilazione.
Seguici su Cagliari Live Magazine
Seguici su Facebook

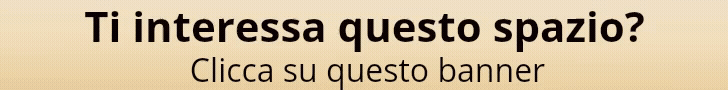




Commenta per primo